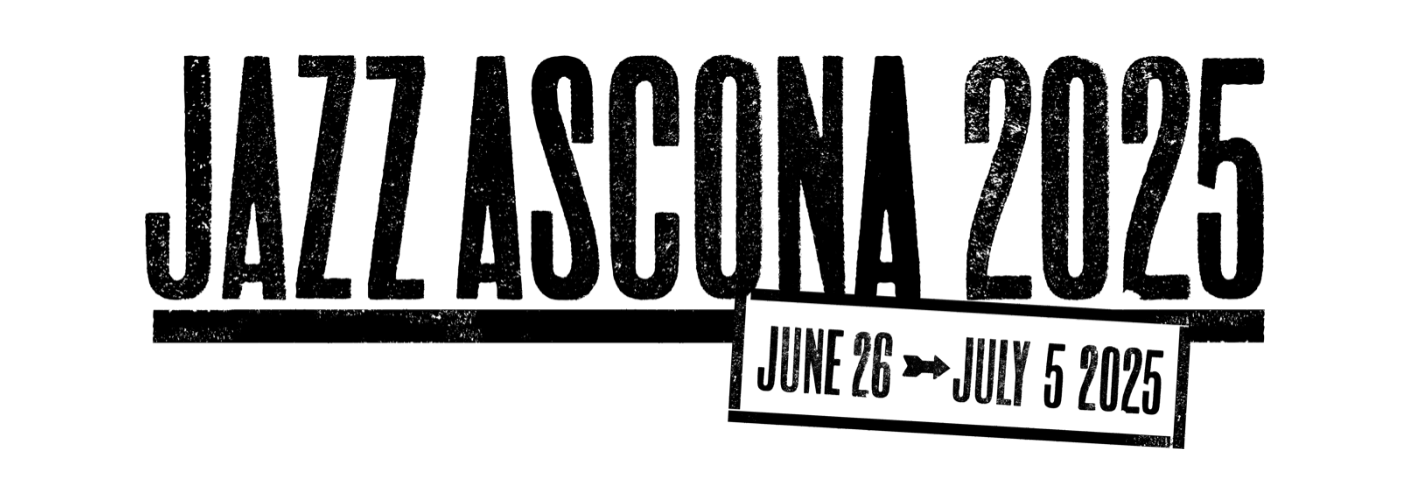Othella Dallas
Othella Dallas premiata con lo Swiss Jazz Award 2019: a 93 anni la Signora del Jazz, del Blues e del Funk infiamma ancora il pubblico con il suo carisma e la sua incredibile energia
Il jazz come pietra filosofale: i novantatré anni di Othella Dallas sono la testimonianza che le passioni, se assaporate fino in fondo, aiutano a vivere meglio la propria età. A JazzAscona – manifestazione che con i suoi 180 concerti movimenterà il lungolago del borgo dal 20 al 29 giugno – l’estrosa vitalità della cantante e ballerina promette di lasciare il segno.
Signora Dallas, ha appena terminato di impartire una lezione di danza e non sembra affatto stanca! Com’è possibile?
Faccio fatica pure io a capirne il motivo, però ho più energia di quando ero giovane. Dentro di me si cela una gioia di vivere talmente irrefrenabile, che neanche so dove mi porterà (ride, ndr.).
Cosa significa per lei ricevere lo Swiss Jazz Award ad Ascona?
Sono molto onorata che ci si interessi alla mia carriera. Ancora fatico a credere che abbiano scelto proprio me per un premio tanto prestigioso.
Si esibirà per la terza volta a JazzAscona. Cosa si ricorda delle sue esibizioni nel 2009 e nel 2011?
Ad essere sincera, penso che a suo tempo non avessero riconosciuto appieno il mio spessore artistico. Ero costretta a correre di qua e di là, esibendomi in piccoli concerti, su piccoli palchi. Per questo motivo mi ero giurata di non tornare più a JazzAscona! Nicolas Gilliet, attuale direttore artistico del Festival, mi ha però convinto a tornare. E in più, mi daranno anche il premio!
Lei è statunitense, ma ha trascorso gran parte della sua vita in Svizzera. In quali circostanze si sente elvetica?
Non mi sento né svizzera, né americana. Per me vale il titolo della canzone di Paul Young «Wherever I Lay My Hat, That’s My Home» (Dovunque io posi il cappello è casa mia).
Che cosa ha apprezzato di più della Svizzera quando è venuta ad abitarci negli anni 50?
A quei tempi in Svizzera regnava una grande libertà artistica, in particolare per quanto riguarda danza e canto. In America, al contrario, si era meno aperti verso le forme d’arte non tradizionali.
A suo tempo non dev’essere stato facile per una ballerina di colore farsi un nome negli Stati Uniti…
No! Alcuni tentavano addirittura di uccidere noi afroamericani, altri almeno ci davano del pane. Ho ancora ben impresse nella mente le code interminabili davanti al panettiere. Parecchie cose sono migliorate rispetto ad allora, tuttavia ci sono ancora molti stenti tra i neri in America.
Il suo talento per il canto e la danza le ha aperto molte porte…
Sì, ma non mi ha risparmiato tanto duro lavoro. Mia mamma, la prima pianista jazz di colore ad esibirsi in radio a St. Louis, era sì un esempio positivo, ma mi comandava senza tanti fronzoli in famiglia. Il suo tono poco accomodante l’ho purtroppo fatto mio. Di questa tendenza soffrono soprattutto i miei allievi. Spesso mi chiedono conto della mia voce imperante. Io rispondo semplicemente: “Fate quello che vi dico e basta!”.
Com’è diventata allieva di Katherine Dunham, la più famosa coreografa afroamericana?
Dopo aver visto il film musical “Stormy Weather”, capii subito che l’avrei voluta come maestra. Andai a St. Louis per un’audizione ed ebbi successo. Katherine Dunham disse di avermi scelto per il mio talento naturale. I soldi per pagarmi le lezioni alla Dunham School of Theatre and Dance di New York li guadagnavo facendo le pulizie.
Cos’ha imparato da Katherine Dunham?
Era ossessionata dalle coreografie e esigeva da noi balllerine impegno totale. I movimenti di ogni singola parte del corpo dovevano combaciare alla perfezione. Dalla Dunham ho imparato che nel ballo è l’attitudine personale a fare la differenza. La danza dev’essere la tua “dannazione”, il tuo destino. Non c’è scampo da tutto questo.
Come conobbe quello che sarebbe poi diventato suo marito, l’ingegnere zurighese Peter Wydler?
Un bel giorno, mentre frequentavo la Dunham School, dal nulla compare una giornalista di Vevey, che faceva delle ricerche sul jazz. Mi diede tre foto di svizzeri che avrebbero volentieri intrecciato un’amicizia epistolare con me e mi consigliò proprio Peter. Ci siamo scritti per due lunghi anni, per poi incontrarci per la prima volta a Parigi a un’esibizione della mia compagnia di danza. Al fidanzamento seguì il matrimiono nel 1949.
Nella sua vita è stata costretta a fare delle scelte tra danza e vita coniugale?
La prima decisione la prese mio marito. Dopo il matrimonio, feci ancora parte per qualche mese della Compagnia Dunham, ma in prossimità di una tournée in Sud America, Peter non volle lasciarmi partire. Mi voleva con lui qui in Svizzera. Tredici anni dopo, quando già mi esibivo come cantante jazz, mi fece visita Quincy Jones, pregandomi di accompagnarlo nella sua serie di concerti in Giappone. Poiché mio marito non era molto contento, rinunciai anche a quell’opportunità.
Le scuole di danza da lei create e condotte nel corso degli anni sono state una consolazione per l’aver rinunciato in nome della famiglia a una carriera ancor più luccicante nello showbusiness?
Sì. Sono state molto importanti per me. Quando dovetti chiudere la scuola a Basilea, regalatami da mio marito nel 1975, sprofondai in una crisi esistenziale. Non pensavo di disporre della forza necessaria per continuare a danzare. Mio figlio mi disse: “Se non vivi più la tua passione, morirai”. Diede seguito a quelle parole, cercandomi un nuovo spazio per la scuola. Stanze in cui ancora oggi tengo i miei corsi.
Per chiudere, la domanda più intrigante: qual è il segreto della sua forma fisica?
Danzare e cantare! Poco tempo fa ho tenuto delle lezioni perfino a Londra. Sono riconoscente per la vita che ho vissuto. Sono curiosa di ciò che mi riserverà il domani e mi godo il presente in ogni sua sfumatura.